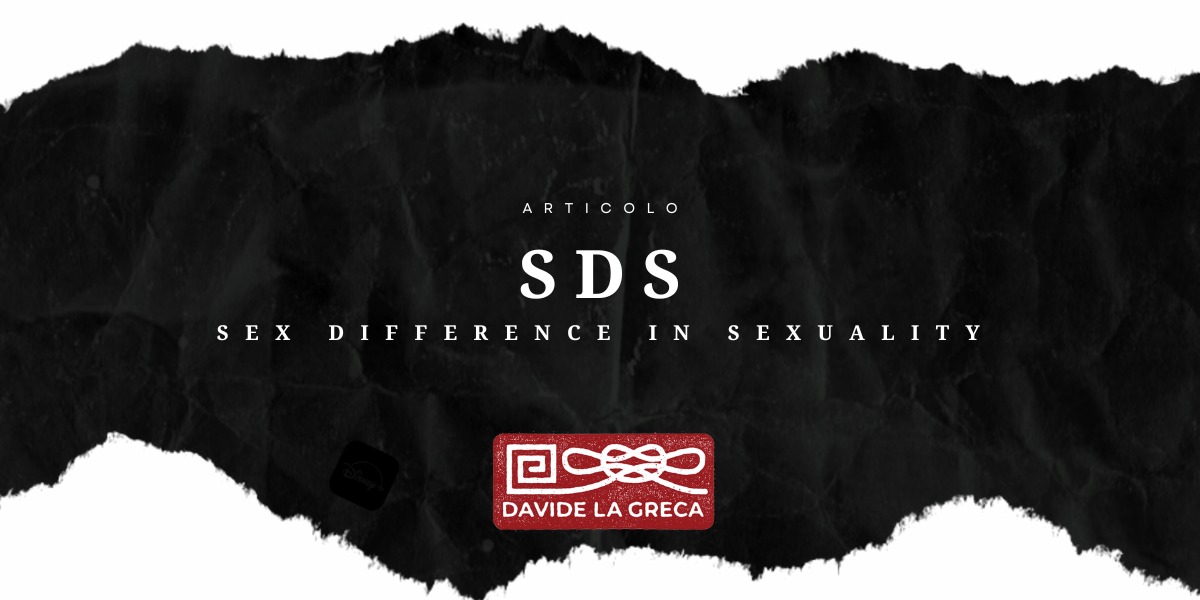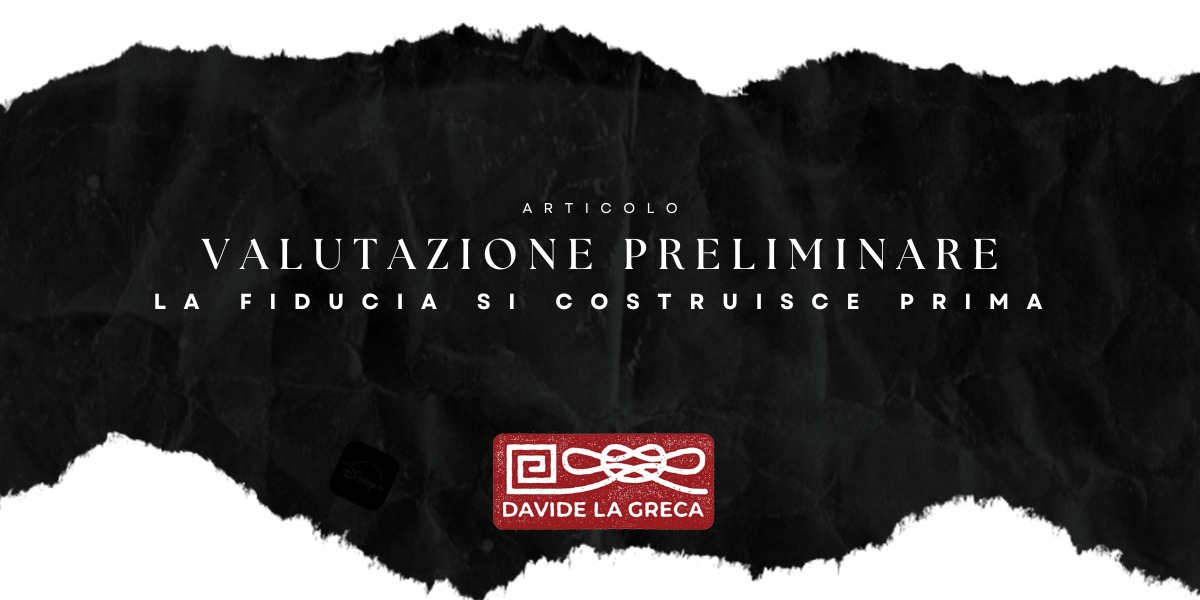Smontare la “chiave e il portone”
C’è una vecchia e tristemente famosa barzelletta che molti hanno sentito almeno una volta.
“Una chiave che apre molte serrature è preziosa; una serratura che si lascia aprire da molte chiavi è scadente.”
Una metafora apparentemente innocua, ma che in realtà veicola uno dei più radicati doppi standard di genere. L’uomo sessualmente attivo viene valorizzato, la donna sessualmente attiva viene svalutata.
Negli ultimi anni la battuta circola meno — forse per un minimo di buon costume — ma la mentalità che rappresenta è tutt’altro che superata. Gli stereotipi di genere continuano a condizionare il modo in cui percepiamo la sessualità: un terreno dove la libertà maschile viene incoraggiata e quella femminile limitata o stigmatizzata.
Per questo è utile ribattere con immagini nuove. Un esempio semplice: “Uno spazzolino usato da una sola persona è igienico; lo stesso spazzolino passato di bocca in bocca diventa sporco.”
Ridurre la complessità delle relazioni umane a paragoni con oggetti inanimati non è solo offensivo: è ridicolo. Un modo diretto e ironico per smontare il sessismo del “portone e della chiave” e restituire dignità al discorso.
Perché partire da qui
Questi luoghi comuni non sono innocui: riflettono doppi standard di genere che attraversano la società, dalla sfera pubblica a quella privata, fino alla sessualità e al mondo del BDSM.
In questo articolo esamineremo le Sex Differences in Sexuality (SDS), ovvero le differenze osservabili nei comportamenti sessuali di uomini e donne, e come esse si intreccino con stereotipi e ruoli sociali.
Mostreremo come i copioni culturali influenzino non solo la sessualità “mainstream”, ma anche pratiche che, come il BDSM, dovrebbero essere laboratorio di libertà e consapevolezza.
Il punto di partenza è chiaro: non esistono serrature e chiavi, ma persone, desideri e relazioni. La sfida è liberarsi da cornici limitanti e immaginare una sessualità più autentica, consapevole e condivisa
Che cosa sono le SDS
Le Sex Differences in Sexuality (SDS) indicano l’insieme delle differenze sistematiche osservabili tra uomini e donne nei desideri, negli atteggiamenti e nei comportamenti sessuali.
Da decenni, psicologi, antropologi e sociologi studiano queste differenze perché coinvolgono fattori biologici, evolutivi e culturali allo stesso tempo. Alcuni risultati si ripetono in molti contesti, gli uomini, in media, riportano un desiderio più alto di sesso occasionale e un numero maggiore di partner desiderati. Mentre le donne, in media, danno più importanza a sicurezza emotiva e stabilità nel partner.
Queste tendenze sono state documentate da numerosi studi interculturali (Trivers, 1972; Buss & Schmitt, 1993). Per esempio, Li et al. (2023) in una ricerca su praticanti BDSM in Cina hanno trovato che circa il 39,9 % degli uomini si identificava come Dominante, mentre il 60,5 % delle donne come Sottomessa. Un altro studio in Belgio (Ten Brink et al., 2021, citato in Li et al., 2023) ha riportato risultati simili: 42,9 % degli uomini come Dominanti, 59,3 % delle donne come Sottomesse.
Questi dati non descrivono destini fissi. In contesti sociali più egualitari (come i paesi nordici ) le differenze tra uomini e donne risultano meno marcate, suggerendo che i fattori culturali modulano fortemente l’espressione dei desideri sessuali. In altre parole: biologia e cultura dialogano, e non si può leggere la sessualità in termini riduzionisti.
Le SDS diventano quindi uno strumento per comprendere perché certi schemi si ripetano nelle nostre società, ma anche per capire come possano essere trasformati. Nel mondo del BDSM, per esempio, ruoli e fantasie sono influenzati sia da inclinazioni individuali sia da copioni culturali: esplorarli significa spesso incontrare questi doppi standard, ma anche la possibilità di superarli.
| Termini di base SDS (Sex Differences in Sexuality): differenze sistematiche osservabili tra uomini e donne nei desideri e nei comportamenti sessuali. Dom/Sub (D/s): dinamiche di Dominazione e Sottomissione in contesti erotici e relazionali, consensuali e negoziati. Switch: persona che alterna ruoli di Dominante e Sottomesso. |
Cornici teoriche per interpretare le SDS
Le Sex Differences in Sexuality non possono essere comprese con una sola lente. Nel tempo, studiosi di discipline diverse hanno proposto modelli interpretativi che mettono in luce aspetti differenti della sessualità e dei ruoli di genere. Non si tratta di stabilire quale teoria sia giusta o definitiva, ma di riconoscere che ciascuna offre spunti di lettura importanti e, al tempo stesso, lascia zone d’ombra. Analizzarle significa comprendere come biologia, società e potere si intrecciano, e perché questi fattori influenzino anche le dinamiche di dominazione e sottomissione nel BDSM.
La prospettiva evolutiva
La teoria evolutiva parte dal concetto di investimento riproduttivo. Secondo Trivers (1972), gli uomini, potendo produrre un numero elevato di gameti a basso costo, avrebbero sviluppato strategie tese a massimizzare il numero di partner, mentre le donne, che sostengono costi biologici molto più alti con gravidanza, parto e cura della prole, avrebbero privilegiato partner capaci di fornire protezione e risorse. Questa idea è stata ripresa e ampliata da Buss e Schmitt con la Sexual Strategies Theory (1993), che ha mostrato come gli uomini tendano a ricercare più frequentemente sesso occasionale e un maggior numero di partner, mentre le donne, mediamente, siano più selettive e orientate a relazioni stabili.
Numerosi studi interculturali hanno confermato che tali differenze ricorrono con una certa regolarità, anche se con intensità variabile. In contesti più egualitari, come i paesi nordici, esse risultano meno marcate, mentre in società patriarcali si accentuano. Questo ci ricorda che l’evoluzione può aver posto delle predisposizioni, ma la loro espressione dipende fortemente dai contesti culturali.
Nel BDSM questa prospettiva può spiegare perché siano relativamente frequenti uomini che si identificano come dominanti e donne che preferiscono la sottomissione. Tuttavia, la centralità del consenso e della negoziazione distingue radicalmente il BDSM da una lettura evolutiva rigida: qui non si tratta di strategie obbligate, ma di ruoli scelti e reinventati.
La prospettiva biosociale
La teoria biosociale proposta da Wood ed Eagly (2002, 2012) sottolinea l’interazione tra predisposizioni biologiche e struttura sociale. Le differenze di forza fisica e i vincoli riproduttivi hanno collocato uomini e donne in ruoli economici e sociali distinti, che a loro volta hanno modellato comportamenti e preferenze sessuali.
Osservando i dati comparativi emergono contrasti interessanti. Nei paesi nordici, dove uomini e donne hanno accesso paritario a risorse e opportunità, le differenze di comportamento sessuale si riducono notevolmente. In contesti con strutture patriarcali più rigide, come alcune aree dell’India o del Medio Oriente, le disparità rimangono invece molto forti.
La storia conferma questa dinamica: in società agricole e patriarcali come la Grecia e la Roma antiche, la sessualità femminile era rigidamente regolata per garantire la legittimità dell’eredità. Invece, presso alcune popolazioni dei nativi americani delle Pianure, prima della colonizzazione, i ruoli di genere erano più fluidi e includevano identità come i Two-Spirit, riconosciute e rispettate nella comunità.
Anche il BDSM riflette queste differenze. In contesti culturali patriarcali lo schema dominante resta quello dell’uomo al comando e della donna sottomessa. Ma nelle comunità moderne, basate su consenso e inclusione, i ruoli diventano più fluidi, invertibili e aperti alla sperimentazione.
La teoria del controllo di genere
La teoria del controllo di genere sposta il discorso dal piano biologico a quello politico e sociale. Qui le differenze sessuali non vengono viste come il prodotto di predisposizioni innate, ma come il risultato di rapporti di potere storicamente costruiti. Religioni, leggi e pratiche sociali hanno contribuito a regolare la sessualità femminile, mentre quella maschile è stata favorita e spesso legittimata.
Le conseguenze di questa logica si vedono ancora oggi: lo slut-shaming, la colpevolizzazione delle vittime di violenza sessuale, la criminalizzazione dell’adulterio femminile in diverse culture. Questi meccanismi confermano l’asimmetria di potere che autorizza l’uomo a desiderare e prendere iniziativa, mentre chiede alla donna di contenere il proprio desiderio.
Applicata al BDSM, questa prospettiva mostra come le scene di dominazione e sottomissione possano diventare luoghi di ribaltamento. Una donna che sceglie di dominare e un uomo che sceglie di sottomettersi possono vivere questa esperienza senza che ciò intacchi la loro dignità. Qui, infatti, ciò che conta non è la conformità a un copione sociale, ma la negoziazione libera e consensuale dei ruoli.
L’ipotesi di intensificazione del genere

Secondo questa ipotesi, le differenze sessuali non sono costanti, ma si accentuano o si riducono a seconda delle pressioni normative. L’adolescenza, per esempio, rappresenta un momento cruciale in cui le aspettative sociali irrigidiscono i comportamenti, incoraggiando i ragazzi a esplorare la sessualità e scoraggiando le ragazze, spesso frenate da stigma e vergogna. Allo stesso modo, nelle società patriarcali con ruoli di genere rigidi, le differenze si amplificano, mentre in contesti egualitari si riducono.
Il BDSM rispecchia bene questa dinamica. In ambienti conservatori si osserva più facilmente il perpetuarsi dei ruoli tradizionali, con uomini dominanti e donne sottomesse. In comunità più aperte, invece, emergono pratiche che mettono in discussione lo stereotipo, come la dominazione femminile, gli uomini sottomessi o la figura dello switch. Questo dimostra che i ruoli sessuali e di potere non sono mai fissati una volta per tutte, ma dipendono dall’interazione tra inclinazioni individuali e contesto culturale.
Sintesi
Le quattro prospettive non si annullano a vicenda, ma si integrano. La biologia suggerisce predisposizioni, la società le modella, il potere le regola, le pressioni normative le intensificano o le attenuano. Portate dentro il BDSM, mostrano come anche in uno spazio costruito sul consenso continuino a filtrare stereotipi culturali, ma anche come questo stesso spazio possa diventare un laboratorio di ribaltamento e di reinvenzione dei ruoli.
Evoluzione storica delle SDS dagli anni ’60 a oggi: femminismo, libertà sessuale e il caso italiano
Le differenze sessuali sistematiche non sono concetti statici. Al contrario, cambiano nel tempo insieme alle trasformazioni culturali e sociali. Guardando al secondo Novecento fino ad oggi, è possibile osservare come le SDS siano state continuamente rilette, contestate e ridefinite, seguendo i movimenti politici, le conquiste legislative, le rivoluzioni culturali e le resistenze patriarcali.
Negli anni Sessanta la sessualità era ancora letta soprattutto attraverso lenti biologiche e psicologiche tradizionali. La sessualità femminile era rigidamente controllata, mentre quella maschile veniva considerata un fatto naturale e accettato. Le ricerche scientifiche tendevano a confermare stereotipi consolidati: l’uomo desiderante, attivo e spinto alla conquista, la donna passiva, selettiva e orientata alla stabilità. Era una visione che rafforzava i ruoli di genere dominanti e legittimava la disparità, senza interrogarsi troppo sui condizionamenti sociali.
Gli anni Settanta segnarono un punto di svolta. Il femminismo mise sotto accusa la costruzione culturale delle differenze e la subordinazione femminile, mostrando come ciò che sembrava “naturale” fosse in realtà il frutto di rapporti di potere. Teoriche come Shulamith Firestone, Kate Millett e Betty Friedan denunciarono il controllo della sessualità femminile come uno strumento fondamentale del patriarcato. Parallelamente, il movimento per la libertà sessuale rese più accessibili contraccettivi, aborto ed educazione sessuale, legittimando il desiderio femminile e riducendo lo stigma che lo circondava. La rivoluzione non fu solo teorica, ma anche legislativa: in Italia arrivarono la legge sul divorzio del 1970 e quella sull’aborto del 1978, due conquiste fondamentali che cambiarono il paesaggio sociale.
Tuttavia, il cambiamento non fu omogeneo. Se negli Stati Uniti e in parte dell’Europa occidentale le nuove idee trovarono maggiore spazio, in Italia il femminismo produsse risultati importanti ma incompleti. Le riforme legali si scontrarono con un tessuto sociale ancora fortemente patriarcale, segnato dal familismo e dall’influenza della Chiesa cattolica. Le norme religiose e morali continuarono a plasmare la percezione della sessualità, e la disuguaglianza economica limitò l’autonomia delle donne, mantenendo così viva la distanza tra diritti formali e libertà reali.
Negli anni Ottanta e Novanta la ricerca scientifica cominciò a integrare approcci più complessi. La psicologia evolutiva mise in risalto il ruolo delle predisposizioni biologiche, mentre la prospettiva biosociale mostrò come i fattori sociali potessero modulare o perfino invertire quelle stesse predisposizioni. Questa maggiore attenzione al contesto sociale contribuì a evidenziare che le differenze sessuali non sono immutabili, ma variabili e plasmabili, a seconda delle condizioni politiche, economiche e culturali. In questo periodo, in Italia, i progressi sul piano della parità di genere furono significativi ma non risolutivi: le donne guadagnarono maggiore visibilità nel lavoro e nella politica, ma senza una piena trasformazione dei rapporti quotidiani e delle mentalità diffuse.
Un altro elemento decisivo emerse nello stesso arco temporale: la crescente visibilità della comunità LGBT. A partire dagli anni Ottanta, e sempre più negli anni Novanta e Duemila, la messa in discussione della norma eterosessuale rese evidente che le differenze tra uomini e donne non sono universali né fisse. Le esperienze queer e transgender dimostrarono che desiderio, sessualità e ruoli non si riducono al binomio maschio/femmina, e che le SDS tradizionali erano solo una delle possibili letture, fortemente condizionate dalle convenzioni culturali. La comunità LGBT non solo ha contribuito a decostruire stereotipi, ma ha anche reso visibile l’importanza del consenso, dell’autonomia e della diversità nell’esperienza sessuale.
Dagli anni Duemila in poi, soprattutto in Occidente, le differenze di genere nella sessualità hanno continuato a ridursi nei contesti più egualitari, mentre in società più tradizionali o segnate da forti pressioni religiose sono rimaste evidenti. Le conquiste della comunità LGBT hanno aperto spazi di espressione più fluidi, ma anche qui i risultati sono stati parziali. In Italia, in particolare, il peso delle tradizioni culturali e religiose ha mantenuto vive resistenze e ritardi: le leggi sul divorzio e sull’aborto sono state conquiste importanti, ma il patriarcato culturale ha limitato l’impatto di queste riforme sulla vita quotidiana e sulle percezioni diffuse.
Negli ultimi anni, con la crescita della consapevolezza sulla fluidità dei ruoli di genere e sulla varietà delle identità sessuali, le SDS sono tornate al centro del dibattito. Da un lato, la ricerca ha mostrato come differenze osservate possano ridursi o perfino sparire in contesti inclusivi. Dall’altro, nuove sfide politiche e sociali hanno rimesso in discussione conquiste che sembravano acquisite. Il rischio di regressione è concreto: il patriarcato e la religione continuano a influenzare le norme sociali, e in molti paesi, Italia inclusa, i diritti sessuali e riproduttivi restano terreno di conflitto.
Guardare a questa storia ci aiuta a capire che le SDS non sono dati di natura, ma fenomeni situati storicamente. Cambiano al cambiare delle condizioni sociali, economiche e culturali. Nel BDSM questo si traduce nella possibilità di rinegoziare continuamente i ruoli, di ribaltare i copioni tradizionali e di creare spazi in cui desiderio e potere possano esprimersi in forme nuove. La lezione degli ultimi sessant’anni è chiara: i doppi standard non scompaiono da soli, vanno riconosciuti, discussi e superati, un passo alla volta.
Dati sul gender gap nelle dinamiche D/s

Le dinamiche di Dominazione e Sottomissione all’interno del BDSM offrono un terreno privilegiato per osservare come le differenze sistematiche tra i sessi vengano percepite e vissute. Molti studi hanno cercato di misurare la distribuzione dei ruoli Dom e Sub tra uomini e donne, con risultati che mostrano tendenze ricorrenti, pur con forti differenze legate al contesto e ai metodi di ricerca.
Uno degli studi più ampi condotti in Asia è quello di Li e collaboratori (2023), che ha raccolto dati su oltre duemila praticanti BDSM in Cina attraverso questionari online. In questo campione, circa il 39,9% degli uomini si identificava come Dominante, mentre il 60,5% delle donne si identificava come Sottomessa. Si tratta di percentuali che rispecchiano gli stereotipi tradizionali, ma che vanno interpretate con cautela, poiché il campione era giovane (in prevalenza tra i 18 e i 30 anni) e reclutato tramite internet, quindi non rappresentativo di tutta la popolazione.
Dati simili sono stati riscontrati anche in Europa. In Belgio, Ten Brink e colleghi (2021) hanno trovato che il 42,9% dei praticanti maschi si identificava come Dominante, mentre il 59,3% delle praticanti femminili come Sottomessa. Anche in questo caso il metodo era basato su survey online, quindi con i limiti di autoselezione che caratterizzano gran parte degli studi sul BDSM, ma la coerenza dei risultati con altre ricerche suggerisce la presenza di un trend piuttosto stabile.
Una prospettiva diversa viene da uno studio condotto da Mollaioli e colleghi (2020), intitolato The Evaluation of Psychosexual Profiles in Dominant and Submissive BDSM Practitioners: A Bayesian Approach. Qui il campione era molto più ridotto (99 partecipanti), ma l’analisi dettagliata ha mostrato che i Dominanti tendevano ad avere livelli più bassi di ansia e tratti di ipersessualità, mentre i Sottomessi riportavano più spesso tratti di vulnerabilità emotiva e sensibilità. Pur non fornendo numeri su larga scala, questo studio mette in evidenza che la scelta di un ruolo non dipende solo dal genere, ma anche da caratteristiche psicologiche e relazionali individuali.
Un altro contributo significativo viene da Wismeijer e van Assen (2013), che in un’indagine condotta nei Paesi Bassi hanno rilevato che circa il 75,6% delle donne praticanti BDSM preferiva la sottomissione, mentre il 48,3% degli uomini preferiva la dominazione. Interessante notare che il 33,4% degli uomini dichiarava invece una preferenza per la sottomissione, e il 16,4% si definiva switch, cioè incline ad alternare i ruoli. Questo dato ricorda che, accanto alle tendenze di genere, esiste sempre un margine importante di fluidità e variabilità individuale.
Infine, Holvoet e colleghi (2017) hanno proposto una stima più ampia sull’interesse verso il BDSM nella popolazione generale, evidenziando che circa il 46,8% delle persone ha avuto almeno una fantasia legata a pratiche di dominazione o sottomissione, mentre solo il 7,6% si identifica come praticante attivo. Anche se questi numeri non distinguono direttamente i ruoli, mostrano che l’interesse è molto più diffuso della pratica effettiva e che la distribuzione dei ruoli va compresa anche alla luce delle barriere sociali e culturali che limitano l’espressione dei desideri.
Nel complesso, questi studi suggeriscono alcune tendenze ricorrenti: gli uomini tendono più spesso a identificarsi come Dominanti, le donne più frequentemente come Sottomesse, ma in entrambi i sessi una quota significativa sceglie ruoli diversi o fluidi. Le differenze non possono essere spiegate solo con la biologia: pesano le aspettative culturali, le norme sociali e i processi di socializzazione. Inoltre, i metodi usati per raccogliere i dati – quasi sempre sondaggi online – favoriscono la partecipazione di persone giovani, urbanizzate e già immerse in comunità digitali, limitando la rappresentatività dei risultati.
La lezione è duplice. I numeri mostrano che i copioni culturali di genere hanno un impatto reale anche in un ambito che si fonda sul consenso e sulla libertà di scelta come il BDSM. La presenza di percentuali non trascurabili di uomini sottomessi, donne dominanti e praticanti switch dimostra che esistono ampi spazi di esplorazione che sfuggono agli stereotipi e che la sessualità non si lascia mai rinchiudere in categorie rigide.
Dominazione maschile: pratiche, preferenze e stereotipi

La dominazione maschile è forse l’archetipo più radicato quando si parla di potere sessuale. Per secoli l’immaginario collettivo ha dipinto l’uomo come colui che guida, prende iniziativa e impone la propria volontà, e la sessualità non è stata un’eccezione. Nelle rappresentazioni popolari, il Dominante maschile appare come un uomo assertivo, sessualmente esperto, capace di esercitare un controllo forte e senza esitazioni. Questo stereotipo, rafforzato dai media e dalla letteratura erotica, continua a influenzare le aspettative di chi entra nel mondo del BDSM.
La cultura popolare recente ha amplificato questo modello. La saga di Cinquanta sfumature di grigio, con il personaggio di Christian Grey, ha reso familiare al grande pubblico l’immagine di un uomo Dominante che impone regole precise di obbedienza. Incarna potere e controllo e trova piacere nella sottomissione della partner. Film come Secretary o 9½ Weeks hanno proposto figure maschili dominanti che usano il sesso come strumento di controllo, spesso in una cornice estetizzata di potere e desiderio. Anche nella letteratura erotica BDSM, il Dominante maschile è di frequente rappresentato come colui che unisce forza, esperienza sessuale e capacità di imporre disciplina.
Se da un lato questi prodotti hanno portato il BDSM all’attenzione del pubblico, dall’altro hanno rafforzato immagini stereotipate e semplificate. Il rischio è che la dominazione maschile venga ridotta a un ruolo quasi “naturale”, inevitabilmente legato alla virilità e alla sessualità penetrativa. Nei dati empirici ritroviamo tracce di questa narrativa: come mostrano le ricerche di Li et al. (2023) e Ten Brink et al. (2021), la maggioranza degli uomini che praticano BDSM tende effettivamente a identificarsi come Dominante. Tuttavia, la realtà è più complessa di quanto queste percentuali possano suggerire.
Essere un Dom maschile consapevole non significa soltanto imporre regole o condurre la scena. Al contrario, implica un insieme di responsabilità che i media raramente mostrano: garantire la sicurezza fisica ed emotiva della partner, saper leggere segnali verbali e non verbali, condurre una negoziazione chiara dei limiti, rispettare confini e prendersi cura del dopo-gioco attraverso l’aftercare. La dominazione maschile, quando è sana e consensuale, non si riduce al controllo, ma include empatia, capacità di osservazione e cura.
Questo elemento è centrale perché distingue nettamente la realtà dalle rappresentazioni mainstream. Dove i film e i romanzi tendono a mostrare l’uomo dominante come freddo, impenetrabile e talvolta persino abusante, la pratica BDSM responsabile si fonda sull’opposto: sull’ascolto, sulla reciprocità e sulla consapevolezza che il potere erotico non può mai essere separato dalla fiducia. Molti uomini che scelgono il ruolo di Dominante lo fanno proprio per esplorare questa forma di cura attraverso il potere, trovando piacere nel guidare e nel proteggere, non soltanto nel comandare.
Non va dimenticato, inoltre, che il modello dominante maschile incontra anche limiti culturali. Come evidenziano le teorie del controllo di genere, l’uomo può legittimamente esercitare dominazione sessuale, ma viene stigmatizzato se prova a estenderla ad altri ambiti non sessuali. Un uomo che praticasse ad esempio forme di financial domination con la propria partner rischierebbe di essere percepito come debole, approfittatore o incapace di gestire la propria vita. Questo doppio standard mostra come la società sia disposta ad accettare la dominazione maschile solo quando resta confinata al terreno del sesso e della virilità, ma la rifiuti quando mette in discussione altre forme di potere.
In questo senso, i dati numerici e l’immaginario culturale convergono, ma non raccontano tutta la storia. La dominazione maschile reale è molto più sfaccettata di quanto non dicano le statistiche o i romanzi. È una pratica che richiede attenzione, responsabilità e capacità di cura. La scena BDSM ci ricorda che il Dominante maschile non è definito soltanto dalla sua assertività, ma dalla capacità di creare uno spazio sicuro in cui l’altro possa affidarsi. È questo aspetto, invisibile alla cultura popolare, a fare la differenza tra uno stereotipo di potere imposto e una relazione erotica basata su negoziazione e consenso.
Dominazione femminile: pratiche, percezioni e stereotipi

Se la dominazione maschile appare come l’archetipo più radicato, la dominazione femminile rappresenta un terreno più complesso e meno legittimato socialmente. Nell’immaginario collettivo, la donna dominante non è quasi mai percepita come una figura “naturale”: la sua autorità viene spesso raccontata come eccezionale, trasgressiva o addirittura deviante. Questo riflette i doppi standard che da sempre regolano la sessualità: l’uomo può legittimamente esprimere desiderio e controllo, mentre la donna è autorizzata a esercitare potere solo se lo fa in forme compatibili con il ruolo sociale che le è stato assegnato.
Nelle rappresentazioni culturali e nei media, la Dominatrice appare di frequente come una figura psicologica più che sessuale. A differenza del Dominante maschile, che viene raffigurato soprattutto nella dimensione erotica, la donna dominante viene rappresentata come colei che gestisce il desiderio altrui con regole, punizioni, privazioni. Nei film e nella narrativa erotica, il Femdom è spesso associato all’umiliazione, al financial domination, alla servitù domestica o al controllo psicologico. Film come Preaching to the Perverted e molta narrativa contemporanea hanno contribuito a diffondere questo immaginario: la donna non è ritratta come colei che gode apertamente della propria sessualità, ma come colei che governa e disciplina quella del partner. È un’immagine che riduce la Dominatrice a un’autorità quasi “asessuata”, dove il potere è esercitato più attraverso la mente e le risorse che attraverso il corpo.
I dati empirici, seppur meno numerosi, confermano la minore rappresentanza delle donne nei ruoli dominanti. Nelle ricerche di Li et al. (2023) in Cina e di Ten Brink et al. (2021) in Belgio, la percentuale di donne che si identificano come Dominanti è decisamente inferiore rispetto a quella degli uomini. La maggioranza delle donne che praticano BDSM tende a identificarsi come Sottomessa, mentre la quota di dominatrici è ridotta e spesso confinata a specifici contesti. Tuttavia, questi stessi studi mostrano anche che esiste una quota significativa di donne switch, capaci di alternare i ruoli, e che la dominazione femminile è più visibile nelle comunità online e nelle scene urbane occidentali rispetto ad altri contesti culturali.
Questa minore presenza non deve essere letta solo in chiave biologica, ma soprattutto culturale. Le norme di genere continuano a rendere più accettabile per un uomo dichiararsi Dominante che per una donna rivendicare lo stesso ruolo. La donna che esercita dominazione sessuale rischia di essere doppiamente stigmatizzata: da un lato come “innaturale” perché trasgredisce al modello femminile tradizionale, dall’altro come “pericolosa” o “eccessiva” se esprime apertamente desiderio sessuale. Per questo, la dominazione femminile viene spesso raccontata attraverso forme non erotiche, come il controllo economico o psicologico, considerate più compatibili con lo stereotipo della donna che cerca sicurezza e stabilità.
La realtà del Femdom, però, è molto più ampia. Nelle comunità BDSM le Dominatrici esplorano modalità di potere che non si limitano alla disciplina o alla gestione delle risorse, ma includono pratiche sessuali esplicite, gioco psicologico e cura relazionale. Una Dominatrice attenta non è meno responsabile di un Dom maschile: deve negoziare limiti, rispettare confini, leggere segnali e prendersi cura del partner. La gratificazione non deriva soltanto dal controllo, ma anche dal consenso e dal riconoscimento reciproco. In questo senso, la dominazione femminile sfida due stereotipi insieme: quello della donna passiva e quello della Dominatrice fredda e disincarnata.
Il BDSM contemporaneo dimostra che una donna può esercitare potere anche in modo erotico e sensuale, senza per questo perdere autorevolezza. Il piacere della Dominatrice può consistere tanto nel dirigere un gioco di umiliazione consensuale quanto nel vivere il proprio desiderio con forza e libertà. La sua autorità non è un difetto da mascherare dietro regole o finanza, ma un’esperienza relazionale che intreccia corpo, mente e emozioni. È qui che la dominazione femminile diventa davvero rivoluzionaria: non nel replicare la durezza di un potere maschile travestito, ma nel proporre nuove forme di intimità in cui controllo e desiderio convivono, liberandosi dagli stereotipi che la società continua a imporre.
SDS, dominazione e stereotipo
Le differenze sessuali sistematiche non si limitano a preferenze individuali o a statistiche accademiche: esse sono profondamente intrecciate con gli stereotipi culturali e con i doppi standard che regolano la sessualità. Quando osserviamo come uomini e donne interpretano i ruoli di dominazione e sottomissione, vediamo riemergere con forza la logica del patriarcato, che concede libertà diverse a seconda del genere.
Nella dominazione maschile, il sesso è quasi sempre dato per scontato. L’uomo che esercita potere erotico sulla donna viene percepito come virile, desiderabile, forte. La sua assertività non solo è accettata, ma è spesso incoraggiata, e persino in contesti di gioco estremo mantiene una forma di legittimità sociale. Un Dom maschile può imporsi sessualmente e al tempo stesso continuare a godere di status e approvazione. Se guarda alla partner come a una sottomessa erotica, la società lo riconosce come “maschio alfa”, in linea con un immaginario che lega la virilità al dominio fisico e sessuale.
La stessa società, però, non offre la stessa legittimazione a forme di dominazione maschile che non passano per il sesso. Un uomo che praticasse, ad esempio, il financial domination, rischierebbe di essere percepito come un approfittatore o un mantenuto, quindi come debole. L’idea che un uomo tragga potere da risorse economiche gestite da una partner mina lo stereotipo della virilità autosufficiente, e rende meno accettabile la sua dominazione. In questo modo il patriarcato mantiene in piedi il copione “sessuale = maschile”, relegando altre forme di potere a una zona ambigua, sospetta o ridicolizzata.
Nella dominazione femminile accade l’opposto. Una donna che esercita potere erotico esplicito rischia subito lo stigma dello slut-shaming. Se afferma il proprio desiderio sessuale, viene accusata di essere “troppo” o di uscire dai confini di ciò che sarebbe “naturale” per una donna. Per essere socialmente accettata, la sua dominazione deve quindi assumere forme indirette: controllo psicologico, umiliazione, disciplina domestica, gestione economica. In questi ambiti la società concede maggiore legittimità, perché rientrano in uno stereotipo che raffigura le donne come attente alle risorse, alla stabilità o al controllo emotivo, ma non come portatrici di un desiderio sessuale attivo e potente.
Gli esempi concreti non mancano. Quando un uomo intrattiene molte relazioni sessuali, è definito “sciupafemmine” o “latin lover”, appellativi che mantengono una connotazione positiva o almeno ammirata. Una donna nelle stesse condizioni è invece bollata come “facile” o “troia”, segno che la società valuta allo stesso modo comportamenti simili con griglie morali radicalmente diverse. In ambito lavorativo, un manager uomo che esercita autorità è considerato determinato, mentre una manager donna con lo stesso stile è giudicata fredda, aggressiva o “poco femminile”. Gli stessi meccanismi agiscono anche nella sessualità: il potere maschile viene normalizzato, quello femminile deve giustificarsi.
Questo doppio standard attraversa anche le comunità BDSM. Nonostante la centralità del consenso, la cultura più ampia continua a filtrare i ruoli. L’uomo dominante può godere della legittimazione che gli viene dal suo genere; la donna dominante deve invece muoversi tra il desiderio di affermare il proprio potere e il rischio di essere stigmatizzata come eccessiva o caricaturale. Allo stesso tempo, un uomo sottomesso rischia di essere deriso come debole o poco virile, mentre una donna sottomessa appare perfettamente “in linea” con l’immaginario culturale.
In definitiva, le SDS non si limitano a descrivere differenze medie tra i sessi, ma mettono in evidenza come la società attribuisca valori diversi agli stessi comportamenti a seconda di chi li mette in atto. È proprio questo che rende i doppi standard così pervasivi: non solo definiscono ciò che è desiderabile, ma stabiliscono anche ciò che è legittimo. Il BDSM contemporaneo ha la forza di rovesciare queste logiche, ma non è immune da esse. Ogni scena di dominazione e sottomissione porta con sé il peso delle norme sociali, e la sfida è riconoscerlo per non riprodurle inconsapevolmente.
Il doppio standard è dunque il punto di contatto tra teoria e realtà quotidiana: ci mostra come la libertà sessuale rimanga diseguale, e come la legittimità del desiderio dipenda ancora troppo spesso dal genere di chi lo esprime. Solo portando alla luce questi meccanismi è possibile trasformarli, creando spazi in cui potere e piacere siano davvero condivisi e non limitati dalle vecchie regole del patriarcato.
Conclusione: la libertà come responsabilità condivisa
Riconoscere le Sex Differences in Sexuality e i doppi standard che le attraversano non è un esercizio teorico. È un atto politico e relazionale, che ci riguarda ogni volta che viviamo, desideriamo e costruiamo le nostre relazioni. Continuare a ignorare come gli stereotipi condizionino la sessualità significa accettare passivamente un sistema che limita tutti: uomini e donne, dominanti e sottomessi, eterosessuali e queer.
Il BDSM, proprio perché si fonda su consenso e negoziazione, ci offre uno spazio privilegiato per ribaltare questi copioni. Ogni scena, ogni relazione D/s, può essere un laboratorio in cui i ruoli non sono dettati da genere o aspettative sociali, ma dal desiderio, dalla fiducia e dalla scelta reciproca. Ma questo richiede coraggio: il coraggio di riconoscere i condizionamenti interiorizzati, di metterli in discussione e di sostituirli con pratiche più autentiche.
La vera libertà sessuale non consiste soltanto nel desiderare, ma nel permettersi di vivere i propri desideri senza dover chiedere il permesso ai vecchi copioni culturali. Significa avere la responsabilità di trattare il potere non come un diritto acquisito, ma come un compito da esercitare con cura, rispetto e attenzione. Essere Dom non vuol dire imporsi; essere Sub non vuol dire annullarsi. Entrambi i ruoli richiedono consapevolezza, ascolto e capacità di prendersi cura dell’altro.
Chiunque partecipi a questo gioco di potere è chiamato a scegliere: ripetere i modelli che la società ci ha imposto, oppure trasformarli in qualcosa di nuovo. La sfida è liberarsi dal doppio standard e creare spazi in cui il piacere e la dominazione non siano ridotti a maschile o femminile, ma siano esperienze di autenticità e reciprocità.
Non si tratta di un compito riservato a pochi, ma di una responsabilità condivisa. Perché la libertà sessuale è fragile: può essere conquistata, difesa e ampliata, oppure persa. E la differenza la fanno le scelte quotidiane, le negoziazioni sincere, la capacità di dire sì e di dire no.
In questo senso, ogni legame diventa un atto politico, ogni corda una possibilità di trasformazione, ogni gesto di dominazione o di sottomissione una scelta di libertà. La domanda che rimane aperta, alla fine, non è “chi domina” o “chi si sottomette”, ma se siamo disposti a costruire una sessualità
| Smontare i doppi standard Le differenze sessuali sistematiche non raccontano soltanto tendenze statistiche: rivelano come la società continui a costruire il desiderio attraverso ruoli e aspettative. La barzelletta della chiave e del portone, con la sua logica semplice e crudele, è ancora lì a ricordarci che gli uomini possono essere celebrati per la stessa libertà sessuale per cui le donne vengono condannate. La dominazione maschile viene accolta come virile se legata al sesso, mentre quella femminile è tollerata solo quando si esprime attraverso il controllo economico o psicologico, come se il desiderio femminile dovesse restare sempre mediato e mai apertamente dichiarato. Il BDSM mostra quanto questi copioni siano potenti, ma anche quanto possano essere ribaltati. Ogni scena diventa una scelta: riprodurre inconsapevolmente lo stereotipo o trasformarlo in qualcosa di nuovo. Le SDS ci aiutano a capire da dove arrivano le differenze, ma non stabiliscono dove dobbiamo andare. La responsabilità è nostra, nel momento in cui decidiamo se restare dentro i limiti del patriarcato o aprirci a una sessualità libera, autentica e condivisa. che non abbia più bisogno di doppie misure per essere vissuta fino in fondo. |
Link:
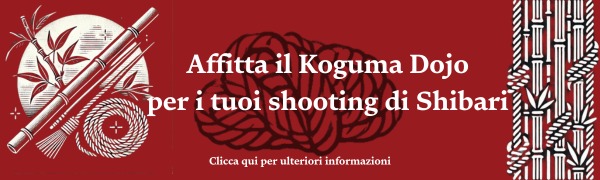
Instagram : https://www.instagram.com/maestrobd2/