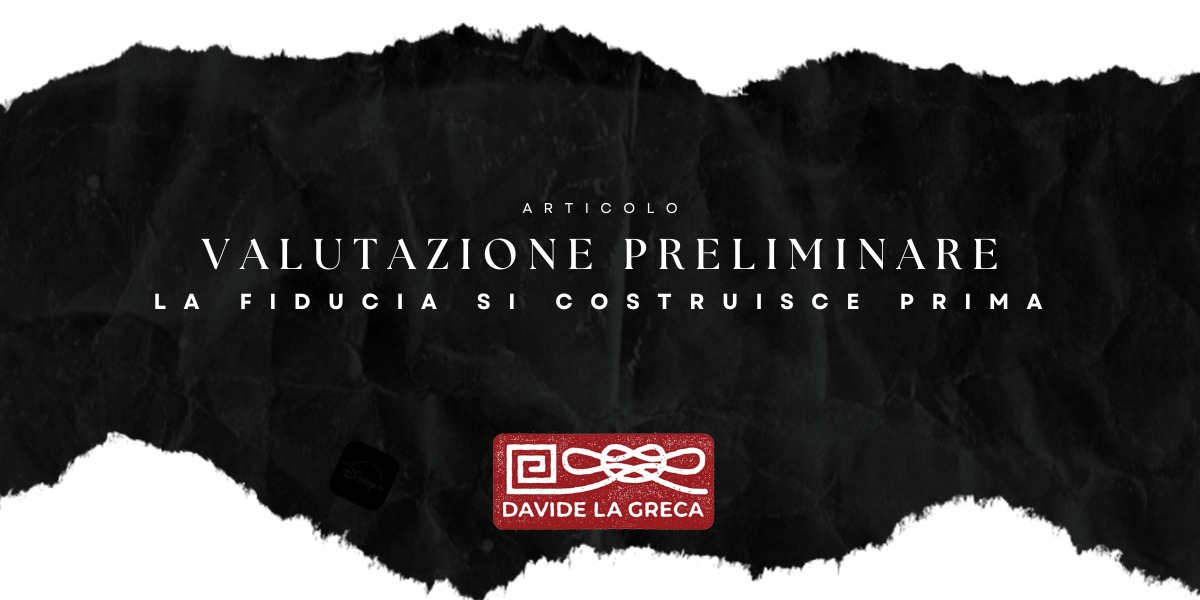Il BDSM come chiave per leggere l’arte performativa contemporanea
Nel corso del Novecento, l’arte ha smesso di rappresentare il corpo: ha iniziato a usarlo, a spremerlo, a offrirlo. L’artista è diventatə non solo autore, ma anche mezzo, materia, vittima, simbolo. E da quel momento, qualcosa si è aperto.
Nelle pieghe della performance art – e in certi linguaggi estremi dell’arte contemporanea – affiorano elementi che a chi vive il BDSM sembrano subito familiari: il gioco dei ruoli, la resistenza, la disciplina, l’abbandono, la centralità del consenso, oppure la sua assenza. Non parliamo di BDSM come ornamento fetish o abbellimento estetico: parliamo del BDSM come grammatica profonda, come struttura simbolica.
Molti artisti hanno scelto di lavorare su temi come il potere, il desiderio, il trauma, il controllo e la vulnerabilità. E hanno trovato nel corpo e nelle sue ferite – reali o metaforiche – il veicolo più diretto, più spietato, più vivo.
In questo articolo voglio accompagnarvi in un piccolo viaggio. Un’esplorazione attraverso le opere di alcuni artisti e artiste che, consapevolmente o no, parlano il linguaggio del BDSM: talvolta erotico, talvolta rituale, talvolta sacro, talvolta violento. Sempre, però, umano.
E in questo viaggio ci sarò anch’io.
Perché come praticante, educatrice e performer Shibari, non posso ignorare quanto il mio lavoro – fatto di corde, ascolto e presenza – sia legato a queste stesse tensioni. Le ho sentite sulla pelle, le ho viste negli occhi. Le ho abitate.
Non vi parlerò di provocazione.
Vi parlerò di rivelazione.
Marina Abramović

Vulnerabilità radicale e sottomissione simbolica
La prima volta che ho visto il video di Rhythm 0, mi è rimasto un nodo in gola.
Non era una scena erotica. Non era neanche una performance sul piacere. Era un campo di battaglia. Eppure, qualcosa dentro di me ha riconosciuto quel gesto: lo stare lì, offrendosi al potere altrui, fidandosi — o illudendosi di poterlo fare.
arina Abramović è considerata una delle madri della performance art. Il suo lavoro ha spesso toccato i confini dell’identità, del dolore, della presenza. Ma c’è un’opera che, per chi vive il BDSM, risuona come una lama:
Rhythm 0 (1974).
Per sei ore, Abramović si mise a disposizione totale del pubblico, in silenzio, senza reagire, con 72 oggetti su un tavolo. Alcuni innocui – una rosa, una piuma, del miele. Altri potenzialmente pericolosi – forbici, un coltello, una pistola carica. Il pubblico poteva usarli su di lei “come voleva”. Lei avrebbe accettato tutto.
All’inizio fu trattata con rispetto. Poi con curiosità. Poi con disprezzo. Le tagliarono i vestiti, le incisero la pelle, le misero la pistola in mano e gliela puntarono alla testa. Solo quando la performance finì e lei tornò a muoversi, il pubblico fuggì.
Quello che è accaduto è, in parte, il riflesso oscuro di una scena BDSM priva di regole, di safe word, di reale consenso. Ma è anche una metafora potente.
Chi domina senza limiti perde la propria umanità.
Chi si sottomette senza potere, diventa oggetto.
Abramović ha mostrato cosa succede quando il contratto viene tolto, quando il ruolo è imposto anziché negoziato. In questo, Rhythm 0 è l’anti-BDSM perfetto: una discesa nell’abisso di ciò che accade quando si sposta il potere, ma senza la responsabilità che quel gesto richiede.
In molte altre opere — da The House with the Ocean View alla serie Rhythm — Abramović ha esplorato la disciplina, l’attesa, la resistenza fisica. Si è privata del cibo, della parola, della privacy. Ha vissuto in galleria sotto osservazione costante. Ha usato il proprio corpo come tempio e prigione, in una forma di auto-sottomissione che richiama certe pratiche di restraint e devozione.
Come nel BDSM più profondo, il suo corpo non è oggetto da guardare, ma canale da attraversare.
Anche nello Shibari, a volte, mi è capitato di osservare quel silenzio: la persona legata entra in uno stato dove il tempo si dilata, lo sguardo si svuota, e il corpo si fa offerta. E se non c’è chi lo accoglie con attenzione, con etica, con rispetto… quello spazio può diventare distruttivo.
Abramović non è una praticante BDSM. Ma ha parlato al cuore delle sue logiche:
Il potere non è mai neutro. Il corpo non è mai muto.
Sta a noi decidere se usarlo per ferire… o per capire.
Bob Flanagan e Sheree Rose
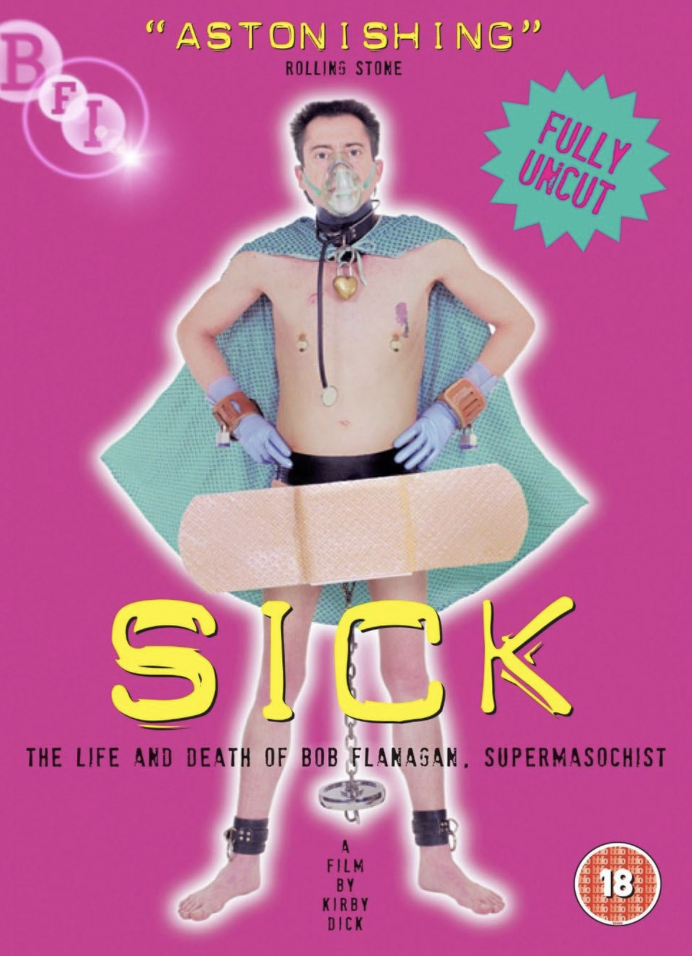
Il dolore come riscatto, identità e sopravvivenza
Ci sono storie in cui il dolore non è una scelta, ma una condizione. E ci sono persone che, pur avendolo subito per tutta la vita, riescono a trasformarlo in linguaggio. La prima volta che ho letto il nome di Bob Flanagan, stavo cercando risposte. Volevo capire perché, per alcuni di noi, il dolore può diventare bellezza. O addirittura potere.
Bob Flanagan è stato un poeta, artista, performer. Soffriva di fibrosi cistica, una malattia genetica grave, degenerativa, che colpisce i polmoni e altri organi. Fin da bambino ha vissuto tra ospedali, operazioni, medicine, sofferenza quotidiana. Ma la sua storia non è quella di una vittima: è quella di qualcuno che ha deciso di ribaltare il proprio destino.
Attraverso il BDSM.
Insieme alla sua compagna e Dominante, Sheree Rose, ha costruito un’intera poetica basata sulla trasformazione del dolore. Il dolore non più come condanna, ma come rituale attivo, consapevole, voluto.
Non più “subito”, ma “gestito”.
Non più malattia, ma gesto politico.
Il loro progetto artistico è radicale, profondamente autobiografico, senza filtri. La performance Visiting Hours (1992) è forse la più potente: una stanza ricostruita come quella di un ospedale, dove Flanagan si sottopone a pratiche BDSM (fruste, aghi, bondage) sotto lo sguardo del pubblico e la cura severa di Rose. Intimità, malattia e sessualità si fondono in un ambiente carico di significati contrastanti: disagio, erotismo, empatia, provocazione.
La forza di Flanagan sta nella sua capacità di mostrare come il corpo malato possa essere anche un corpo potente. Il dolore fisico — che non poteva evitare — veniva rielaborato attraverso il sadomasochismo in qualcosa che poteva finalmente controllare. Il corpo non era più un nemico, ma un campo da esplorare, da modificare, da onorare.
La sottomissione diventava libertà.
Molti dei suoi testi, delle sue immagini e delle sue azioni oscillano tra il grottesco e il sacro. Come in Nailed, dove è crocifisso letteralmente con dei chiodi. Come in Sick, dove mostra il corpo in tutta la sua fragilità, ma anche nella sua forza volontaria. Flanagan non cercava la pietà. Cercava la verità.
Anche nello Shibari ho visto persone affrontare traumi antichi usando la corda come strumento di riscrittura. Non è una medicina. Non è una terapia. Ma è uno spazio dove, con il giusto contenimento, si può risignificare la sofferenza. Come Flanagan, anche noi — quando esploriamo con consapevolezza — possiamo trasformare la ferita in parola, il silenzio in grido, il limite in forza.
Flanagan diceva:
“Il dolore è ciò che conosco meglio. Lo conosco da quando sono nato. E ho deciso che se dovevo soffrire, almeno ne avrei fatto qualcosa di mio.”
Questo, forse, è il cuore più profondo del BDSM.
COUM Transmissions

Il feticismo come rivolta sociale e linguaggio rituale
Se il BDSM è un sistema di regole, ruoli e consapevolezza, COUM Transmissions ha fatto l’opposto: ha preso quell’estetica, l’ha spogliata di ogni rassicurazione e l’ha usata come arma.
Una provocazione pura. Un caos rituale. Una risata oscena contro ogni ipocrisia sociale.
Fondato a fine anni Sessanta da Genesis P-Orridge e Cosey Fanni Tutti, COUM è stato un collettivo di arte performativa, musica, pornografia e anarchia. Le loro azioni non si limitavano a scioccare: volevano colpire al cuore la morale borghese, l’ordine culturale, la facciata del decoro.
La mostra più celebre — e scandalosa — fu Prostitution (1976), all’Institute of Contemporary Arts di Londra. In quella stanza c’erano fotografie pornografiche, abiti usati in scene di sesso simulato, oggetti sadomaso, immagini di auto-mutilazione, scarti e feticci.
La stampa britannica gridò allo scandalo: “degenerati”, “nemici della società”, “terrorismo culturale”.
Eppure, quello che COUM stava facendo era più lucido di quanto sembri.
Usavano il BDSM come grammatica per denunciare i sistemi di controllo e repressione del corpo, del desiderio, dell’identità. Invece di nascondere la sessualità, la buttavano in faccia al pubblico. Ma non per eccitare: per interrogare.
Chi guarda?
Chi consente?
Chi domina cosa?
Le loro performance erano sporche, disturbanti, viscerali. Includevano finti riti religiosi, travestimenti, pratiche sadomaso simulate, sangue, feci, pelli, droghe. Tutto ciò che è marginale, ripugnante, bandito dalla cultura “normale” veniva messo al centro della scena, in un gioco consapevole di potere, disgusto e attrazione.
Non era BDSM “da manuale”. Ma ne usavano i simboli — corde, fruste, posture, vincoli, ruoli — per rivelare qualcosa che ancora oggi fatichiamo a guardare: che le nostre identità sono costruite su desideri repressi, ruoli sociali imposti, e un controllo sistematico del corpo.
Da educatore BDSM, quando guardo COUM non penso alla scena perfetta. Penso alla necessità di rompere la scena ideale, per vedere cosa c’è sotto.
Anche nelle dinamiche più consapevoli, se non portiamo attenzione ai nostri automatismi, rischiamo di diventare caricature. O peggio, riproduttori di quello stesso potere che diciamo di voler esplorare.
Il lavoro di COUM non è comodo. Ma serve.
Serve per ricordarci che la forma — elegante, pulita, estetica — può ingannarci.
E che il desiderio, quando è davvero libero, non è mai innocuo.
È un atto politico.
Vito Acconci

Spazio, corpo e violazione dei limiti invisibili
C’è un tipo di dominazione che non passa per la corda, né per la frusta. È fatta di sguardi, silenzi, spazi invasi.
Una dominazione che non si impone con forza, ma con intimità.
E che proprio per questo, inquieta di più.
Vito Acconci non ha mai dichiarato un legame con il BDSM. Eppure, molte delle sue performance si muovono in quella zona grigia dove il consenso è implicito, l’esposizione è scelta, ma il disagio è reale.
È il luogo del voyeurismo, dell’invasione, del controllo sottile.
Seedbed (1972) è forse la sua opera più disturbante.
Acconci si nasconde sotto una rampa di legno costruita all’interno della galleria.
Mentre i visitatori camminano sopra di lui, lui si masturba. Parla. Fantastica ad alta voce sul loro passaggio.
Tutto è amplificato. Il pubblico lo sente. Non lo vede. Ma è dentro la scena, anche se non voleva esserlo.
Chi è il soggetto?
Chi è l’oggetto?
Chi domina chi?
Acconci rende ogni spettatore un involontario partner. Ogni passo è un atto che attiva il desiderio dell’artista. Ogni movimento produce eccitazione.
È una dinamica BDSM rovesciata: non c’è un sottomesso visibile, ma uno spettatore sottomesso all’imbarazzo.
Non c’è un contratto, ma un contesto.
Non c’è un ordine, ma un’intromissione.
In altri lavori, come Rubbing Piece o Conversions, il corpo diventa luogo di trasformazione attraverso gesti ossessivi, ripetitivi, disturbanti. Sfregare la pelle finché si arrossa. Tentare di cancellare la mascolinità visiva. Mettere in discussione i segni identitari e il proprio corpo come mappa da riscrivere.
C’è una forma di auto-sottomissione anche in questo.
Come in certi giochi solitari, in cui si sperimenta la vergogna, la soglia del dolore, il controllo di sé, senza nessuno che guardi… eppure immaginando sempre uno spettatore.
Anche nello Shibari capita. Legare qualcuno che sa di essere visto, ma non guardato direttamente.
O legarsi per qualcuno che non c’è, ma che si immagina.
Il potere dello sguardo assente è uno dei più intensi.
Acconci ci costringe a domandarci fino a che punto siamo consapevoli dei confini.
Ci sono limiti fisici, certo. Ma ce ne sono altri, invisibili.
Lo spazio personale. Il diritto di non essere coinvolti. La responsabilità dell’intimità.
Nel BDSM, li negoziamo.
Nell’arte, a volte, li scavalchiamo.
Ma in entrambi i casi, quello che ci mettiamo in gioco è sempre lo stesso: il corpo. Il nostro. E il corpo, anche quando tace, non mente mai.
Vanessa Beecroft

Il corpo femminile tra oggettivazione e potere silenzioso
Ci sono silenzi più violenti di mille parole.
E ci sono corpi che sembrano immobili, ma sotto la superficie trattengono tensioni che non si possono ignorare.
Le performance di Vanessa Beecroft sono fatte di questo silenzio: rigido, costretto, bellissimo e disturbante. Donne nude o seminude, in piedi per ore, immobili, esposte. Non si toccano. Non parlano. Non si muovono.
Sono lì. A disposizione dello sguardo.
In una delle sue opere più famose, VB55, venti donne vestite come soldatesse nude, con scarpe identiche e postura neutra, occupano uno spazio solenne, quasi sacro. Il pubblico entra e le osserva. Non accade nulla, ma il disagio cresce minuto dopo minuto, perché ci si accorge che quelle donne non stanno performando: stanno sopportando.
Beecroft non fa BDSM.
Ma nelle sue performance c’è una dinamica che noi riconosciamo bene:
controllo, immobilità, potere distribuito in modo asimmetrico.
Lei, come artista, decide tutto: l’abbigliamento, l’atteggiamento, i tempi, la scena.
Le performer eseguono. Si sottomettono. Con il corpo. Con il volto. Con la presenza.
In questo, il suo lavoro ha qualcosa di profondamente dominante.
Non nel senso erotico del termine, ma in quello rituale: crea un quadro in cui il corpo femminile viene fissato, immobilizzato, disciplinato — e poi osservato.
Il pubblico è libero di guardare, ma non di interagire. E questo sguardo, così passivo, si trasforma in una forma di voyeurismo istituzionalizzato.
Da fuori, qualcuno potrebbe vedere bellezza, ordine, estetica.
Io, invece, ci vedo anche tensione muscolare, sfinimento, soggettività sospesa.
Beecroft ha sempre dichiarato di voler mostrare la fragilità, la pressione estetica e l’identità sociale femminile come performance quotidiana.
E in effetti, cosa c’è di più BDSM della pressione a stare dentro un ruolo, a restare in una posa che non ti appartiene, a esibirti secondo uno sguardo che non hai scelto?
Anche nello Shibari, ho visto corpi assumere pose bellissime solo in apparenza.
Sotto, c’era fatica, sforzo, adattamento.
Ma la differenza è che in una sessione consapevole, posso chiederle:
“Come stai lì dentro?”
“Ti reggo ancora?”
“Vuoi uscire?”
Nella scena di Beecroft, invece, il controllo è assoluto e muto.
E questo rende il tutto ancora più potente. E più inquietante.
Ron Athey

Sacrificio, rito e trascendenza nel dolore estremo
Ci sono performer che vogliono essere guardati.
Ron Athey, invece, vuole che tu veda davvero.
E quando lo fai, non puoi più tornare indietro.
La sua arte è corpo vivo, corpo che sanguina, corpo che invoca. Non c’è metafora, non c’è distanza, non c’è comfort. Ogni gesto è reale. Ogni ferita è vera. Ogni rito è un atto di fede — e di resistenza.
Athey è sieropositivo. Cresciuto in un contesto cristiano fondamentalista, ha trasformato la sua biografia in liturgia. Le sue performance uniscono sadomasochismo, spiritualità, body modification e rituali arcaici in un linguaggio che parla di stigmate, espiazione, sopravvivenza queer e catarsi fisica.
Nella celebre Martyrs & Saints (1992), l’artista e i suoi collaboratori incidono simboli sulla pelle, imprimono i corpi sul tessuto come se fossero reliquie, si offrono in sacrificio.
Non c’è niente di simulato.
Il sangue scorre. L’altare esiste. La sacralità è brutalmente vera.
Nel BDSM, siamo abituati a parlare di dolore come strumento.
Con Athey, il dolore è via di accesso. Non per il piacere, ma per la trasformazione.
Lui non cerca l’estetica del gesto, ma l’alterazione dello stato di coscienza.
Ogni azione è una soglia, un passaggio, una possibilità di purificazione.
Anche nella sospensione con ganci, nei riti di scarificazione, nei tableaux ispirati a santi e martiri, non c’è mai un intento decorativo.
C’è un’urgenza.
C’è la volontà di guardare in faccia ciò che il mondo respinge: la malattia, la morte, la vergogna, la contaminazione.
E trasformarle in qualcosa di altro: una liturgia laica, una resistenza incarnata.
Nel mio percorso con le corde, ho visto persone arrivare a uno stato simile.
Non c’è sangue. Non c’è trauma. Ma c’è un momento in cui il corpo non è più solo corpo.
Diventa tempio, residuo, portale.
E tu che lo leghi, devi scegliere: resti in superficie, o entri con lei?
Athey entra. Sempre.
E non lo fa per compiacere. Lo fa perché sa che la scena più radicale è quella che non può essere ripetuta, quella in cui tutto può accadere, e ogni ferita è anche una forma di linguaggio.
Guardare Athey significa confrontarsi con l’essenza del BDSM rituale:
non il gioco, ma il fuoco.
Non il gesto, ma il significato.
Non l’effetto, ma l’intenzione.
E soprattutto, con una verità che pochi hanno il coraggio di ammettere:
alcuni di noi non cercano il sollievo. Cercano la soglia.
Orlan
Il corpo come scultura vivente e atto di disobbedienza estetica
C’è chi subisce il proprio corpo.
C’è chi lo modifica per piacere agli altri.
E poi c’è chi, come Orlan, lo trasforma in un atto di guerra.
A partire dagli anni ’90, l’artista francese Orlan ha fatto del suo volto e del suo corpo il campo di battaglia della propria pratica artistica. Non attraverso performance fisiche nel senso classico, ma attraverso una serie di interventi chirurgici veri, documentati e trasmessi pubblicamente, con cui ha ridefinito la propria immagine secondo un progetto concettuale: diventare, pezzo dopo pezzo, la reincarnazione di diverse icone femminili dell’arte occidentale.
Naso alla Gérôme, mento alla Botticelli, fronte alla Gioconda.
Non per diventare più bella, ma per denunciare la costruzione culturale della bellezza.
Per dimostrare che il corpo, come il genere, come l’identità, può essere smontato, riscritto, hackerato.
Ogni operazione era accompagnata da testi, costumi, immagini, musiche. L’artista restava cosciente, spesso interagiva col pubblico o col chirurgo.
Il tavolo operatorio diventava palcoscenico, il bisturi pennello, l’anestesia strumento per mantenere il controllo.
Nel BDSM, spesso pensiamo alla trasformazione del corpo come a qualcosa che accade durante la scena. Un’evoluzione temporanea, uno stato transitorio.
Con Orlan, invece, la trasformazione è permanente.
Non si torna indietro.
Il gesto è definitivo, anche se simbolico.
Il legame con il BDSM non è esplicito, ma profondo, l’invasione consenziente del corpo, il dolore reso significante attraverso il rituale e la sfida al canone, al controllo, all’immagine imposta
Nel mio lavoro come Dominante, ho incontrato molte persone che volevano usare la scena per riscriversi, non solo per eccitarsi.
Un gesto, una parola, una corda messa in un certo modo — e qualcosa cambiava dentro.
Orlan ha fatto questo in modo chirurgico, letterale, politico.
Ci insegna che non esiste un “corpo naturale”, ma solo corpi narrati, disciplinati, modificati.
Che ogni scelta estetica è un atto politico.
E che dominare davvero se stessə può voler dire rifiutare l’immagine che ci è stata data, per crearne una nuova, anche scomoda, anche incomprensibile.
Orlan ha detto:
“Il mio corpo è lo strumento attraverso cui penso. È la mia materia, il mio strumento, la mia memoria, il mio archivio e il mio mezzo di comunicazione.”
Nel BDSM più profondo, non è forse lo stesso?
Saturno Butto
Sacro e profano, flagello e bellezza nel corpo martirizzato
Guardare un dipinto di Saturno Butto è come entrare in una cattedrale dove tutto è sbagliato.
O forse è tutto finalmente sincero.
La sua pittura è figurativa, iperrealista, sontuosa. Ma sotto la perfezione tecnica, c’è carne legata, ferita, incatenata. Corpi maschili e femminili in posture di abbandono o di tensione. Santi e martiri, crocifissi e flagellanti. Bondage che non è gioco, ma liturgia erotica e ossessione visiva.
Butto non è un performer. Dipinge. Ma la scena è sempre lì: lo spazio rituale, il corpo esposto, la violazione simbolica, l’intimità esibita.
L’iconografia religiosa — croci, aureole, ex voto, ceri, reliquie — si fonde con fruste, corde, latex, lingerie.
E non si capisce più dove finisca la redenzione e dove inizi il piacere.
I suoi modelli non sembrano mai soffrire davvero.
Eppure sono attraversati.
Da un dolore implicito. Da una forza che li tiene in quella posa, che li inchioda a uno stato emotivo carico, intenso, immobile.
Sono soggetti e oggetti insieme.
Proprio come nella dinamica BDSM più potente.
C’è qualcosa di profondamente italiano in Butto: il gusto per la teatralità, la luce drammatica da Caravaggio, il culto della bellezza come peccato e salvezza. Ma c’è anche un pensiero contemporaneo sul corpo: non più macchina, ma simbolo. Non più strumento, ma enigma.
Nel mio modo di legare, ho spesso sentito questa tensione: l’estetica che serve a fermare il tempo, ma che non è mai neutra.
Una posizione non è solo bella: è scelta, è costruzione, è potere.
E se non ascolto ciò che quel corpo sta dicendo — dietro la posa, dentro il silenzio — allora sto solo usando l’estetica come maschera.
Butto toglie la maschera.
E ci mostra la verità del corpo nella sua contraddizione più profonda:
essere fragile e glorioso allo stesso tempo.
In questo senso, la sua pittura è BDSM.
Non perché rappresenta pratiche esplicite, ma perché usa la cornice sacra per incorniciare la profanazione del controllo.
E viceversa.
È una pittura che ti osserva mentre la guardi.
E ti chiede, senza parlare:
che cosa stai davvero desiderando?
Anna Uddenberg
Il corpo come dispositivo: tra estetica femminile e servitù performativa
Le opere di Anna Uddenberg sembrano uscite da un centro estetico futurista.
Manichini iperfemminili, curve esasperate, outfit sportivi o sexy, corpi piegati in posizioni impossibili, in bilico tra equilibrio e disfunzione.
Ma non fatevi ingannare: non c’è nulla di seducente in quei corpi.
Sono macchine di piacere per altri.
Accessori da trasporto.
Oggetti addestrati all’efficienza servile.
Uddenberg lavora con sculture iperrealiste e installazioni che mettono in scena una femminilità spinta all’assurdo, simile a quella proposta dai social, dal porno, dalla moda commerciale. Ma invece di erotizzarla, la ingabbia in ambienti freddi, plastificati, surreali.
Le sue donne — creature immobili, gambe aperte, bacini sollevati, mani tese — sembrano bloccate in una sequenza senza fine: offrire, sorreggere, flettersi, rimanere.
Il BDSM qui è sotterraneo, ma evidente.
Ogni postura ricorda un ordine eseguito.
Ogni oggetto è un segno di contenzione o di uso: valigie che diventano poggiapiedi, sedili che si fondono con i genitali, trolley ergonomici che inglobano il corpo stesso.
Uddenberg non rappresenta una scena BDSM, ma qualcosa di più profondo e disturbante: il modo in cui la società ha sessualizzato, vincolato e automatizzato il corpo femminile attraverso aspettative di ruolo.
Da praticante e da osservatrice, vedo in quelle posture qualcosa di familiare:
la flessibilità portata al limite, la disposizione al compiacimento, la posa come obbligo invisibile.
Ma nel BDSM — quello vero, consapevole, negoziato — posso chiedere:
“Questa posizione ti nutre o ti svuota?”
Nelle opere di Uddenberg, invece, il corpo non risponde.
È muto. Programmato. Progettato per servire, non per scegliere.
Anche lo Shibari può diventare questo, se perdiamo il contatto con chi abbiamo davanti.
Se seguiamo solo l’estetica, l’ideale, il controllo.
Uddenberg ci mostra cosa succede quando la prestazione prende il posto del desiderio:
non c’è più gioco. Solo funzione.
In fondo, ogni scultura di Uddenberg sembra chiedere:
Quante volte ci siamo piegatə così… per piacere a qualcun altro?
E quante volte abbiamo confuso quella posa per potere?
Santiago Sierra
Il corpo come merce, il potere come ferita strutturale
Non c’è niente di eccitante nell’arte di Santiago Sierra.
Eppure, chiunque abbia riflettuto sul concetto di dominazione — anche dentro il BDSM — non può ignorare ciò che lui mostra:
che il potere, nella sua forma più brutale, è spesso silenzioso, contrattualizzato e… legale.
Sierra è un artista spagnolo, noto per performance e installazioni che impiegano corpi reali di persone marginalizzate, pagate per compiere gesti semplici ma devastanti:
- Stare immobili per ore.
- Essere tatuate con una linea nera sulla schiena.
- Dormire in una scatola.
- Bloccare l’ingresso a una galleria con il proprio corpo.
In 160 cm Line Tattooed on 4 People (2000), paga quattro uomini tossicodipendenti per farsi tatuare una linea dritta lungo la schiena.
In Workers Who Cannot Be Paid, Remain in the Gallery (2000), fa “esporre” lavoratori migranti illegalizzati, pagati in nero, come parte dell’opera.
Tutto è documentato. Tutto è consensuale. Tutto è pagato.
E proprio per questo è inaccettabile.
Queste opere non parlano di potere.
Lo mettono in scena. Lo riproducono. Lo fanno toccare.
Non c’è un Dominante figurato.
C’è il sistema.
E il sistema, come in certe derive tossiche del BDSM, usa il consenso come scudo, mentre sfrutta corpi reali in condizioni di necessità.
Nel nostro mondo, ci piace pensare che la differenza tra gioco e abuso sia la volontarietà.
Ma Sierra ci costringe a fare una domanda più scomoda:
quanto è davvero libero un consenso ottenuto con il denaro, in condizioni di povertà, migrazione, dipendenza, esclusione?
Anche nel BDSM dobbiamo stare attenti:
non sempre la parola “sì” è sufficiente.
Se non siamo capaci di leggere il contesto, quel sì può essere un “non posso dire di no”.
Sierra non giudica.
Ma ci sbatte in faccia la nostra complicità.
Se guardi l’opera, sei parte della dinamica.
Se accetti che sia arte, accetti anche il compromesso.
Se ti indigna… forse è proprio lì che inizia il cambiamento.
Per me, come educatrice e Dominante, il lavoro di Sierra è un monito:
il potere non è mai solo un gioco.
È una struttura.
E possiamo o usarlo per creare spazi sicuri, oppure per perpetuare ingiustizie ben mascherate.
Nel BDSM cerchiamo la verità attraverso il rito.
Sierra, senza rito, ci mostra il volto più nudo e concreto della dominazione: quella che non chiede amore, solo obbedienza.
Conclusione
Corpi che parlano, legami che mostrano, desideri che rivelano
Abbiamo attraversato stanze sacre e ospedali profanati.
Abbiamo visto corde, aghi, sangue, silenzi.
Abbiamo riconosciuto noi stessi — chi pratica il BDSM, chi lo osserva, chi lo studia — in gesti artistici che forse non lo nominano, ma lo incarnano.
Da Marina Abramović a Ron Athey, da Orlan a Santiago Sierra, il corpo non è mai stato solo un mezzo.
È stato il luogo dove accade la verità.
Verità scomode, erotiche, spirituali, politiche.
Verità che nessuna parola può spiegare da sola, perché stanno nella pelle, nel limite, nel gesto ripetuto o nella postura imposta.
Il BDSM — nella sua forma più profonda — non è imitazione di potere.
È una domanda sul potere.
Una domanda su chi guarda, chi conduce, chi obbedisce.
Una domanda che l’arte contemporanea ha saputo porre con radicalità, sporcandosi le mani, invadendo lo spazio sacro della galleria come fosse una stanza di gioco.
Una stanza dove si sperimenta.
Dove si regredisce.
Dove si evolve.
E come in una buona sessione, anche nell’arte più estrema, non tutto si capisce subito.
A volte ci si turba.
A volte si desidera.
A volte si fugge.
Ma chi sa restare, chi accetta di sentirsi a disagio, chi non cerca solo conferme…
scopre che là dove c’è una ferita, c’è anche una possibilità.
Una possibilità di rivedere se stessə.
Di riscrivere il corpo.
Di risignificare la vergogna.
Di toccare, finalmente, quella soglia che separa il gesto vuoto dal rito trasformativo.
Che sia arte, o BDSM,
la domanda è la stessa:
Se il corpo è il tuo linguaggio… cosa vuoi davvero dire?
Link :

Instagram :
https://www.instagram.com/maestrobd2/